 Vi ripropongo un articolo di Giorgio Nebbia del 1991 in cui ricordava gli albori del movimento ecologista italiano, i pregiudizi ideologici dei gruppi post-sessantotto, la capacità del Pci di cogliere l’importanza della questione con un convegno organizzato dall’Istituto Gramsci nel 1971.
Vi ripropongo un articolo di Giorgio Nebbia del 1991 in cui ricordava gli albori del movimento ecologista italiano, i pregiudizi ideologici dei gruppi post-sessantotto, la capacità del Pci di cogliere l’importanza della questione con un convegno organizzato dall’Istituto Gramsci nel 1971. Sembra incredibile che solo venti anni fa l’ecologia fosse in Italia una scienza praticamente sconosciuta. Anzi, le prime timide idee che penetravano nel nostro paese venivano bollate come «la scienza delle contesse», estranee alla cultura rigidamente marxista del movimento operaio. Eppure proprio in quel periodo, gli inizi degli anni settanta, gli operai iniziavano le prime vere battaglie «ecologiche» per difendere la salute di chi abitava attorno alla fabbrica. Ci fu però un caso di lungimiranza: il Pci organizzò nel 1971 un seminario a Frattocchie, relatore Giovanni Berlinguer…
L’ecologia è sbarcata in Italia nella primavera del 1970, anno europeo della conservazione della natura. Il 22 aprile fu dichiarato «giornata mondiale della Terra» e fu come se gli occhi di milioni di persone si aprissero sui guasti provocati da un uso imprevidente della tecnica. I fiumi coperti di schiuma, i cieli sporcati dai fumi industriali, l’aria irrespirabile della città, i monumenti corrosi dagli acidi, e poi gli effetti «ecologici» negativi di azioni internazionali, come l’uso dei pesticidi, anche durante la guerra del Vietnam, le esplosioni di bombe atomiche, la diga di Assuan, eccetera, apparvero all’opinione pubblica mondiale come i segni di un mondo incapace di prevedere e prevenire. Ne venne una diffusa protesta e ribellione – una contestazione (come si diceva ancora allora) ecologica – che si diffuse nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nei congressi, negli appelli dei saggi. (Abbastanza curiosamente questa pagina importante dei movimenti e delle idee non ha una storia e solo adesso nell’Archivio centrale dello Stato comincia a costituirsi un archivio storico ecologico con l’afflusso di alcuni archivi privati). Come è stato accolto a sinistra questo movimento di protesta? Non c’è dubbio che si trattò, all’inizio, di un movimento di carattere borghese: difficilmente si sarebbe potuto riconoscere degli agitatori rivoluzionari nei padri fondatori e nei militanti di Italia nostra – la prima associazione «ecologica» italiana – o del più giovane Wwf. La contestazione di sinistra dapprima rigettò l’«ecologia» come «scienza dei padroni» o «delle contesse»: facevano poca fatica, i «signori», a battersi contro le fabbriche inquinanti, contro l’automobile, contro la speculazione sulle coste, loro che avevano redditi sicuri e ville nel verde. Nessuna salvezza si sarebbe potuta avere per la Terra – sostennero molti – se non fosse stato scardinato il sistema capitalistico, con il suo modo di produrre le merci, la sua avidità di denaro, nessuna salvezza senza le lotte operaie. E poi Marx non parla di ecologia, ma di rapporti di produzione ed è la produzione di merci che libera le masse dal bisogno. A dire la verità, già negli anni Sessanta, la classe operaia aveva condotto le sue lotte «ecologiche» per la sicurezza e per minore nocività nell’ambiente di lavoro. Erano stati gli operai i primi a riconoscere che i fumi e gli acidi «dentro» la fabbrica colpivano i loro occhi e polmoni: si trattava ora di estendere la lotta al miglioramento delle condizioni di lavoro «fuori» delle fabbriche, dove, poi, vivevano le mogli e i figli dei lavoratori. La nuova attenzione per l’ecologia offriva l’occasione per condurre un’unica battaglia contro gli inquinamenti, prodotti nel nome del profitto, e per la salute, per quella dei polmoni degli esseri umani, e anche per quelle dei monumenti e del verde e degli animali. Con contraddizioni, perché il potere economico rispose alla contestazione col solito ricatto occupazionale: se volete l’aria pulita io chiudo e licenzio, mettendo i lavoratori contro gli «ecologi» – o, come sarebbero stati chiamati più tardi – gli «ecologisti». In questa vivace atmosfera l’Istituto Gramsci e il Pci organizzarono a Frattocchie, proprio venti anni fa, nei primi giorni del novembre
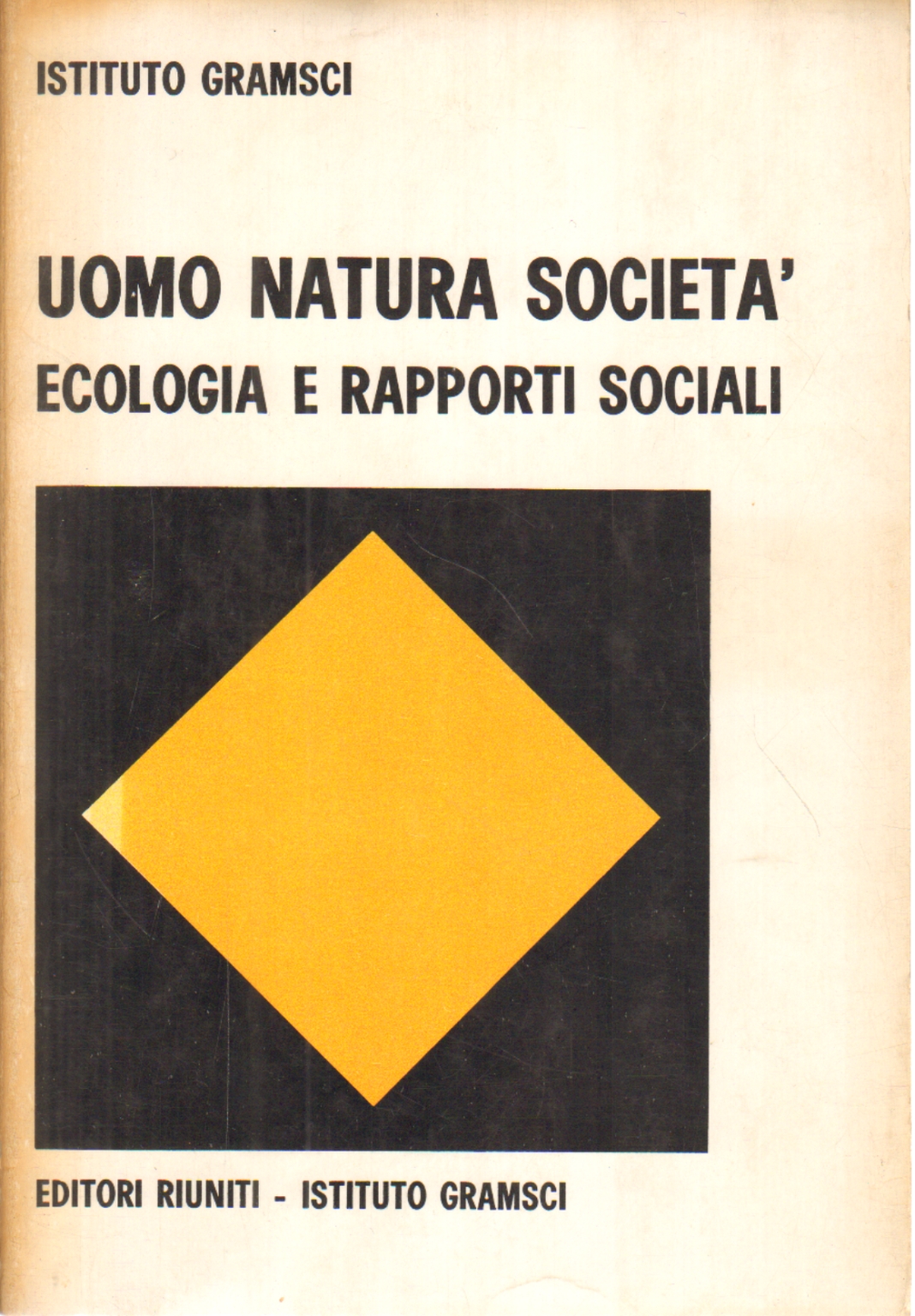 1971, un convegno dal titolo: «Uomo natura società». Gli atti furono pubblicati quasi subito dagli Editori Riuniti e costituiscono ancora oggi un documento – ormai reperibile solo in poche biblioteche – di grande interesse. Tanto per cominciare il Pci invitò iscritti e non iscritti, avviando un dialogo che avrebbe portato il partito, negli anni successivi, a mobilitare un gran numero di studiosi e intellettuali intorno all’elaborazione di un lungimirante «progetto» (il «progetto a medio termine») per gli anni che si annunciavano difficili per l’ecologia e per l’economia. La relazione introduttiva del seminario di Frattocchie fu affidata a Giovanni Berlinguer (ora senatore del Pds, che fu il primo responsabile della commissione Ambiente del Pci e che curò la parte «ecologica» del progetto a medio termine); la sua relazione, partendo dalla ricostruzione delle lotte operaie per l’ambiente di lavoro, mise in evidenza che non si sarebbe potuta avere liberazione ecologica senza un coinvolgimento della classe operaia. Il filosofo Giuseppe Prestipino analizzò il pensiero di Marx ed Engels sul rapporto uomo-natura, con considerazioni che avrebbe ampliato nel libro: «Natura e società», pubblicato l’anno dopo, nel 1972, dagli Editori Riuniti (anch’esso ormai introvabile). Mi vengono in mente, fra gli altri, gli interventi di Dario Paccino (che nel 1973 avrebbe scritto il graffiante saggio: «L’imbroglio ecologico», pubblicato da Einaudi, sul falso amore ecologico della borghesia e che ha continuato a scrivere provocatori libri sull’argomento, come l’ultimo: «I colonnelli verdi»); di Tomas Maldonado (ora professore al Politecnico di Milano), che l’anno prima aveva scritto il libro: «La speranza progettuale», pubblicato da Einaudi; di Virginio Bettini (ora parlamentare europeo verde) che sostenne che «l’ecologia è rossa». Raffaello Misiti, un compagno scomparso alcuni anni fa, parlò degli aspetti psicologici del rapporto uomo-natura; è scomparso da molti anni anche il compagno Pistolese che trattò, come avrebbe fatto ancora in libri successivi, il problema degli effetti ambientali dell’energia. Ettore Biocca parlò dell’esplosione demografica e Giorgio Di Maio del ruolo della ricerca scientifica e dell’insegnamento nei confronti dell’ecologia. Dai molti interventi che emergono dalle pagine ingiallite del volume degli atti del seminario di venti anni fa, appare l’interesse e la vivacità di un dibattito che riscopriva, quasi con sorpresa, nelle pagine di Marx e di Engels una straordinaria attenzione per gli effetti della produzione e del capitalismo sulla natura. E non c’è da meravigliarsene: i manoscritti di Marx del 1844 seguono di pochi anni il viaggio di Darwin intorno al mondo, un evento che nell’Inghilterra vittoriana ebbe una enorme risonanza; gli scritti di Engels sulle condizioni della classe operaia in Inghilterra sono contemporanei ai movimenti socialisti, utopisti e anarchici di riprogettazione delle città, liberate dai fiumi ridotti a fogne, da rifiuti e miasmi. Sono degli stessi anni, intorno al 1860, le opere di Liebig, che Marx conosce e loda nel primo libro del Capitale, sulla nutrizione dei vegetali e sull’impoverimento che le colture eccessive determinano nella fertilità del suolo, con l’enunciazione della «legge del minimo» che anticipa i concetti di «limite» da non superare nello sfruttamento della terra. I vari saggi sulla dialettica della natura di Engels sono contemporanei alla pubblicazione dei libri di Darwin e alle polemiche successive; il libro di Haeckel, nel quale è stata usata per la prima volta la parola ecologia, indicata come scienza dell’«economia della natura», è del 1866, l’anno prima della pubblicazione del Capitale. Il convegno di Frattocchie del 1971 fu, quindi, un evento culturale da non dimenticare. Adesso che per tanti il comunismo è morto e sepolto e le opere di Marx ed Engels sono da buttare al macero, è tutto da buttar via anche quello che fu detto e scritto allora sui rapporti fra marxismo ed ecologia? A mio parere non è affatto certo che le leggi del libero mercato siano capaci di risolvere tutti i problemi di degrado ambientale e di scarsità delle risorse naturali; alcuni problemi richiedono il ricorso a concetti che sono estranei all’economia politica tradizionale, come la solidarietà internazionale, la modificazione dei modelli di produzione e di consumi e di sprechi, quelli di una più equa distribuzione delle risorse materiali. Lo stesso concetto di «sviluppo sostenibile» o di «società sostenibile» difficilmente si può tradurre in regole giuridiche e in pratica politica senza mettere in discussione le definizioni di «crescita» e «sviluppo», senza ricorrere ad una pianificazione delle merci, delle città, del territorio anche contro le convenienze dell’economia capitalistica. Vorrei concludere raccomandando, soprattutto ai giovani militanti del movimento ambientalista, molti dei quali, per loro fortuna, nel 1971 non erano ancora nati, di andare a pescare, in qualche biblioteca pubblica, le pagine di quel dibattito lontano, forse per scoprire che l’ansia di quegli anni era molto più vicina a tante aspirazioni attuali di quanto non si pensi.
1971, un convegno dal titolo: «Uomo natura società». Gli atti furono pubblicati quasi subito dagli Editori Riuniti e costituiscono ancora oggi un documento – ormai reperibile solo in poche biblioteche – di grande interesse. Tanto per cominciare il Pci invitò iscritti e non iscritti, avviando un dialogo che avrebbe portato il partito, negli anni successivi, a mobilitare un gran numero di studiosi e intellettuali intorno all’elaborazione di un lungimirante «progetto» (il «progetto a medio termine») per gli anni che si annunciavano difficili per l’ecologia e per l’economia. La relazione introduttiva del seminario di Frattocchie fu affidata a Giovanni Berlinguer (ora senatore del Pds, che fu il primo responsabile della commissione Ambiente del Pci e che curò la parte «ecologica» del progetto a medio termine); la sua relazione, partendo dalla ricostruzione delle lotte operaie per l’ambiente di lavoro, mise in evidenza che non si sarebbe potuta avere liberazione ecologica senza un coinvolgimento della classe operaia. Il filosofo Giuseppe Prestipino analizzò il pensiero di Marx ed Engels sul rapporto uomo-natura, con considerazioni che avrebbe ampliato nel libro: «Natura e società», pubblicato l’anno dopo, nel 1972, dagli Editori Riuniti (anch’esso ormai introvabile). Mi vengono in mente, fra gli altri, gli interventi di Dario Paccino (che nel 1973 avrebbe scritto il graffiante saggio: «L’imbroglio ecologico», pubblicato da Einaudi, sul falso amore ecologico della borghesia e che ha continuato a scrivere provocatori libri sull’argomento, come l’ultimo: «I colonnelli verdi»); di Tomas Maldonado (ora professore al Politecnico di Milano), che l’anno prima aveva scritto il libro: «La speranza progettuale», pubblicato da Einaudi; di Virginio Bettini (ora parlamentare europeo verde) che sostenne che «l’ecologia è rossa». Raffaello Misiti, un compagno scomparso alcuni anni fa, parlò degli aspetti psicologici del rapporto uomo-natura; è scomparso da molti anni anche il compagno Pistolese che trattò, come avrebbe fatto ancora in libri successivi, il problema degli effetti ambientali dell’energia. Ettore Biocca parlò dell’esplosione demografica e Giorgio Di Maio del ruolo della ricerca scientifica e dell’insegnamento nei confronti dell’ecologia. Dai molti interventi che emergono dalle pagine ingiallite del volume degli atti del seminario di venti anni fa, appare l’interesse e la vivacità di un dibattito che riscopriva, quasi con sorpresa, nelle pagine di Marx e di Engels una straordinaria attenzione per gli effetti della produzione e del capitalismo sulla natura. E non c’è da meravigliarsene: i manoscritti di Marx del 1844 seguono di pochi anni il viaggio di Darwin intorno al mondo, un evento che nell’Inghilterra vittoriana ebbe una enorme risonanza; gli scritti di Engels sulle condizioni della classe operaia in Inghilterra sono contemporanei ai movimenti socialisti, utopisti e anarchici di riprogettazione delle città, liberate dai fiumi ridotti a fogne, da rifiuti e miasmi. Sono degli stessi anni, intorno al 1860, le opere di Liebig, che Marx conosce e loda nel primo libro del Capitale, sulla nutrizione dei vegetali e sull’impoverimento che le colture eccessive determinano nella fertilità del suolo, con l’enunciazione della «legge del minimo» che anticipa i concetti di «limite» da non superare nello sfruttamento della terra. I vari saggi sulla dialettica della natura di Engels sono contemporanei alla pubblicazione dei libri di Darwin e alle polemiche successive; il libro di Haeckel, nel quale è stata usata per la prima volta la parola ecologia, indicata come scienza dell’«economia della natura», è del 1866, l’anno prima della pubblicazione del Capitale. Il convegno di Frattocchie del 1971 fu, quindi, un evento culturale da non dimenticare. Adesso che per tanti il comunismo è morto e sepolto e le opere di Marx ed Engels sono da buttare al macero, è tutto da buttar via anche quello che fu detto e scritto allora sui rapporti fra marxismo ed ecologia? A mio parere non è affatto certo che le leggi del libero mercato siano capaci di risolvere tutti i problemi di degrado ambientale e di scarsità delle risorse naturali; alcuni problemi richiedono il ricorso a concetti che sono estranei all’economia politica tradizionale, come la solidarietà internazionale, la modificazione dei modelli di produzione e di consumi e di sprechi, quelli di una più equa distribuzione delle risorse materiali. Lo stesso concetto di «sviluppo sostenibile» o di «società sostenibile» difficilmente si può tradurre in regole giuridiche e in pratica politica senza mettere in discussione le definizioni di «crescita» e «sviluppo», senza ricorrere ad una pianificazione delle merci, delle città, del territorio anche contro le convenienze dell’economia capitalistica. Vorrei concludere raccomandando, soprattutto ai giovani militanti del movimento ambientalista, molti dei quali, per loro fortuna, nel 1971 non erano ancora nati, di andare a pescare, in qualche biblioteca pubblica, le pagine di quel dibattito lontano, forse per scoprire che l’ansia di quegli anni era molto più vicina a tante aspirazioni attuali di quanto non si pensi. L’Unità, 4 dicembre 1991








Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.