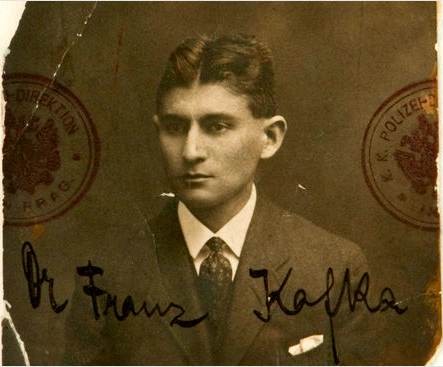 Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, una potente ondata di antisemitismo investì tutta l’Europa, dalla Russia zarista alla Francia repubblicana. Il tradizionale antigiudaismo religioso si unì qui a nuove manifestazioni più “moderne”, basate su argomenti razziali, “sociali” o nazionalisti. Assunse forme diverse: pogrom, rivolte popolari, discorsi e pubblicazioni antisemite, emarginazione legale da territori o professioni, processi antisemiti. Non risparmiò l’Impero austro-ungarico e la sua provincia ceca, dove l’antisemitismo era diffuso sia tra la maggioranza ceca che nella minoranza di lingua tedesca. Come reagì Franz Kafka, ebreo ceco di cultura tedesca, all’antisemitismo?
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, una potente ondata di antisemitismo investì tutta l’Europa, dalla Russia zarista alla Francia repubblicana. Il tradizionale antigiudaismo religioso si unì qui a nuove manifestazioni più “moderne”, basate su argomenti razziali, “sociali” o nazionalisti. Assunse forme diverse: pogrom, rivolte popolari, discorsi e pubblicazioni antisemite, emarginazione legale da territori o professioni, processi antisemiti. Non risparmiò l’Impero austro-ungarico e la sua provincia ceca, dove l’antisemitismo era diffuso sia tra la maggioranza ceca che nella minoranza di lingua tedesca. Come reagì Franz Kafka, ebreo ceco di cultura tedesca, all’antisemitismo?
Il rapporto di Kafka con l’ebraismo era altamente ambiguo, un’ambiguità riassunta nel famoso commento del 1918 nei suoi quaderni in ottavo: “Io… non ho afferrato l’orlo del mantello da preghiera ebraico – che ora vola via da noi – come hanno fatto i sionisti”. [1] Con uno spirito simile, in una lettera a Grete Bloch datata 11 giugno 1914, si descrive come una persona asociale, esclusa dalla comunità a causa del suo “ebraismo non sionista e non praticante (ammiro il sionismo e ne sono nauseato)”. [2] Un’altra affermazione ben nota sembra ancora più negativa: “Cosa ho in comune con gli ebrei? Non ho quasi niente in comune con me stesso, e dovrei restare tranquillamente in un angolo, felice di poter respirare”. [3]
D’altro canto, si abbonò alla rivista pubblicata dai suoi amici sionisti (Max Brod, Hugo Bergmann, Felix Weltsch), Selbstwehr (Autodifesa), e vi pubblicò persino il suo scritto Vor dem Gesetz . E, soprattutto, nutriva un vivo interesse per la cultura ebraica dell’Europa orientale, per la lingua yiddish, su cui tenne una conferenza nel 1912, e per il teatro yiddish: uno dei suoi attori, Ytzhak Löwy, divenne suo amico.
Nonostante la sua simpatia per gli Ost-Juden , Kafka sapeva bene di essere un West-Juden assimilato, con pochi legami con la tradizione religiosa o culturale ebraica. In una lettera a Max Brod, del giugno 1921, descrive la sua generazione di scrittori ebrei di lingua tedesca a Praga come esseri curiosi che “con le zampe posteriori sono incollati all’ebraismo dei padri, mentre le zampe anteriori non riuscivano a trovare un nuovo terreno”. [4]
Questa ambivalenza, documentata in molti scritti, non gli impedì di reagire con forza all’antisemitismo: si trattava, infatti, di una reazione comune a molti ebrei europei, la cui inquieta identità ebraica veniva provocata, amplificata o risvegliata dalle aggressioni antisemite. Come giurista, Kafka fu particolarmente colpito dalle manifestazioni legali dell’antisemitismo di Stato: i processi antisemiti del suo tempo. Come cercheremo di dimostrare, essi costituiscono il contesto storico del celebre romanzo Der Prozess.
Il Processo di Franz Kafka , scritto tra il 1914 e il 1915, fu pubblicato solo molti anni dopo la sua morte; solo una parte, la breve parabola “Davanti alla legge”, apparve, come abbiamo detto, sulla rivista “Selbstwehr”. Ricordiamo brevemente gli episodi principali del romanzo.
Joseph K viene arrestato una mattina, apparentemente vittima di una calunnia. I due poliziotti che lo arrestano si rifiutano di fornire qualsiasi spiegazione per questo provvedimento – che non assume la forma di una vera e propria prigionia, ma rimane come una sorta di minaccia sospesa sulla sua testa, mentre gli viene permesso di continuare le sue normali attività. Viene giudicato da una Corte che impedisce qualsiasi accesso ai suoi Giudici e che non riconosce la difesa legale, ma si limita a “tollerarla”. Questa Corte, la cui gerarchia si estende all’infinito ( unendlich ), e il cui comportamento è inspiegabile e imprevedibile, finge di essere infallibile; i suoi procedimenti rimangono segreti e l’atto di accusa non è accessibile all’imputato, né ai suoi avvocati, e ancor meno al pubblico in generale. L’imputato non è quindi in grado di difendersi, poiché non sa di cosa viene accusato… Dopo questo procedimento del tutto oscuro, la Corte invia due scagnozzi a giustiziare lo sfortunato Joseph K.
Il libro è diventato uno dei romanzi più famosi del XX secolo , nonché uno straordinario film di Orson Welles, ed è stato oggetto di un’enorme quantità di interpretazioni diverse e contraddittorie.
Alcune di esse hanno una forte tendenza conformista. Un esempio lampante sono quelle letture del romanzo che presuppongono la colpevolezza di Joseph K e quindi la legittimità della sua condanna. Ad esempio, Erich Heller – i cui scritti su Kafka sono tutt’altro che privi di interesse – dopo una discussione dettagliata della parabola “Davanti alla Legge” conclude: “c’è una certezza che non viene toccata né dalla parabola né dall’intero libro: la Legge esiste, e Joseph K deve averla offesa in modo terribile, perché alla fine viene giustiziato con un coltello da macellaio a doppio taglio – sì, a doppio taglio – che gli viene conficcato nel cuore e lì girato due volte”. [5] Applicato agli eventi del XX secolo , questo argomento porterebbe alla seguente conclusione: se questa o quella persona, o anche qualche milione di persone, vengono giustiziate dalle autorità, è certamente perché devono aver offeso terribilmente la Legge… In effetti, nulla nel romanzo non suggerisce che il povero Joseph K abbia ‘offeso terribilmente la Legge’ (quale?) e ancor meno che meritasse una condanna a morte!
Altri lettori, più attenti, riconoscono che nel romanzo non c’è nulla che lasci intendere la colpevolezza del protagonista, ma sostengono che nei capitoli che Kafka non ebbe il tempo di scrivere ci sarebbe stata, senza dubbio, «la spiegazione della colpa di Joseph K, o almeno delle ragioni del processo» [6] . Ebbene, si può speculare ad libitum su cosa Kafka avrebbe scritto, o avrebbe dovuto scrivere, ma nel manoscritto così come ci è pervenuto, una delle idee forti del testo è proprio l’assenza di qualsiasi «spiegazione delle ragioni del processo», nonché l’ostinato rifiuto di tutte le istanze interessate – poliziotti, magistrati, tribunali, carnefici – di fornirne una.
Tutti i tentativi dei vari interpreti di rendere Joseph K. colpevole di qualcosa inevitabilmente danneggiano la prima frase del romanzo, che afferma semplicemente: Jemand musste Joseph K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens verhaftet – ‘Qualcuno deve aver calunniato Josef K., poiché, senza aver fatto nulla di male, una mattina venne arrestato’. [7] È importante osservare che questa frase non è affatto presentata come l’opinione soggettiva dell’eroe – come egli manifesta nei vari passaggi del romanzo in cui proclama la sua innocenza – ma come un’informazione ‘oggettiva’, fattuale come la frase successiva: ‘La cuoca della signora Grubach (…) non è venuta oggi’. [8]
Ciò che è comune a tutti questi tipi di sforzi esegetici è che neutralizzano o cancellano la straordinaria dimensione critica del romanzo, il cui motivo centrale è, come Hannah Arendt comprese così bene, “il funzionamento di un’astuta macchina burocratica in cui l’eroe viene colto innocentemente”. [9] Molti lettori sono rimasti colpiti dal carattere profetico del romanzo; che sembra prevedere, con la sua immaginazione visionaria, la giustizia degli stati totalitari del XX secolo . Bertolt Brecht fu uno dei primi a proporre una simile interpretazione, fin dal 1937: “le democrazie borghesi portano nel loro intimo più profondo la dittatura fascista, e Kafka dipinse con una grandiosa immaginazione ciò che più tardi divennero i campi di concentramento, l’assenza di qualsiasi garanzia legale, l’assoluta autonomia dello stato (…)”. [10] Lo stesso argomento non potrebbe applicarsi, mutatis mutandis , all’URSS stalinista? Ancora una volta è Brecht – pur essendo un fedele compagno di strada del movimento comunista – a dirlo, in una conversazione con Walter Benjamin su Kafka, nel 1934, cioè prima ancora dei processi di Mosca: «Kafka aveva un solo problema, quello dell’organizzazione. Ciò che lo ha preso è l’ angoscia dello Stato-Formicaio, il modo in cui gli esseri umani alienano da sé le loro forme di vita comune. E ha previsto alcune delle manifestazioni di questa alienazione, come ad esempio i metodi della GPU». Brecht ha aggiunto: «Si vede con la Gestapo cosa può diventare la Ceka». [11]
Una simile lettura è un legittimo omaggio alla lungimiranza dello scrittore praghese, che seppe cogliere le tendenze, già nascoste ai suoi tempi come sinistre virtualità, degli stati europei “costituzionali”. Tuttavia, ci offre ben poco sulle sue motivazioni e sulle sue fonti di ispirazione.
Inoltre, questi riferimenti a posteriori ai cosiddetti “stati di eccezione” (dittature, totalitarismi) potrebbero oscurare una delle idee potenti del romanzo: l'”eccezione”, cioè la soppressione dell’individuo da parte degli apparati statali, ignorandone i diritti, è la regola – sto parafrasando una formula di Walter Benjamin nelle sue Tesi sul concetto di storia (1940). In altre parole: Il Processo affronta la natura alienata e oppressiva degli Stati moderni, compresi quelli che si autodefiniscono “Stati di diritto”. Ecco perché, nelle prime pagine del romanzo, è detto chiaramente – ancora una volta, dalla voce neutrale del narratore: “K. viveva tuttavia in uno Stato di diritto ( Rechtsstaat) , la pace regnava ovunque, tutte le Leggi erano in vigore, chi osò attaccarlo a casa sua?” [12]
Non è in un futuro immaginario, ma negli eventi storici contemporanei, che si dovrebbe cercare la fonte d’ispirazione per Il Processo. [13] Tra questi fatti, i grandi processi antisemiti del suo tempo furono un esempio lampante di ingiustizia di Stato. I più (in)famosi furono il processo Tisza (Ungheria 1882), il processo Dreyfus (Francia 1894-99), il processo Hilsner (Cecoslovacchia, 1899-1900) e il processo Beiliss (Russia, 1912-13). Nonostante le differenze tra i vari regimi statali – assolutismo, monarchia costituzionale, repubblica – il sistema giudiziario condannò, talvolta alla pena capitale, vittime innocenti il ??cui unico crimine era quello di essere ebrei.
Il caso Tisza fu un processo per “omicidio rituale” contro quindici persone appartenenti a una piccola comunità ebraica di un villaggio dell’Ungheria settentrionale (1882-83), accusate di aver ucciso una giovane gentile, Esther Solymosi, e di averne raccolto il sangue in sinagoga per preparare il pane azzimo pasquale ( matzot). Naturalmente, il tragico evento non poteva aver toccato Kafka direttamente, essendo nato nel 1883. Ma certamente ne era a conoscenza, attraverso varie fonti giornalistiche o letterarie. I forti sentimenti che provava al riguardo emergono in modo impressionante in una lettera dell’ottobre 1916 alla sua fidanzata Felice Bauer, che contiene un commovente riferimento a un dramma teatrale, Omicidio rituale in Ungheria (Berlino 1914), dello scrittore ebreo tedesco Arnold Zweig, che tratta del processo Tisza: “L’altro giorno ho letto ‘Omicidio rituale in Ungheria’ ( Ritualmord in Ungarn) di Zweig; le sue scene soprannaturali sono deboli come mi sarei aspettato da ciò che conosco dell’opera di Zweig. Le scene terrestri, d’altra parte, sono intensamente vive, tratte senza dubbio dagli eccellenti documenti del caso. Ciononostante, non si riesce a distinguere del tutto tra i due mondi; si è identificato con il caso e ora ne è sotto l’incantesimo. Non lo vedo più come prima. A un certo punto ho dovuto smettere di leggere, sedermi sul divano e piangere ad alta voce. Sono anni che non piango’. [14] Poiché questa è una delle poche – forse l’unica! – menzione del pianto nella Corrispondenza o nei Diari di Kafka, è ovvio che egli fu profondamente commosso dalla storia di questo orribile processo antisemita, in cui un ragazzo ebreo, Mortiz Scharf, di 13 anni, fu costretto a testimoniare contro suo padre e la comunità ebraica. Il riferimento agli ‘eccellenti documenti’ del processo suggerisce che Kafka avesse letto questo materiale prima di scoprire l’opera di Arnold Zweig; molto probabilmente aveva già qualche informazione sull’affare Tisza quando, nel 1914, cominciò a scrivere Der Prozess.
Paradossalmente, la più (in)famosa vicenda antisemita del suo tempo, il processo Dreyfus, è appena menzionata nei suoi scritti. Ad esempio, il nome di Alfred Dreyfus non compare una sola volta nei suoi Diari. In effetti, non sappiamo cosa ne pensasse, anche se si può essere certi che, come tutti i cittadini ebrei o persino europei di questa generazione, conoscesse gli episodi principali di questo evento traumatico. Si tratta di una sorprendente mancanza di interesse, che deve ancora essere spiegata. Alcuni autori pretendono che Dreyfus fosse di fondamentale importanza per lui, ma questo non sembra un argomento molto convincente. Ad esempio, secondo Frederick Karl, il processo Dreyfus è “il caso giudiziario archetipico sullo sfondo del Processo” [15] , ma ci sono poche prove a sostegno di questa valutazione. C’è ancora meno da dire sull’affermazione di Sander Gilman secondo cui “l’affare Dreyfus perseguitò Kafka per tutta la sua vita adulta” così come sul suo tentativo di identificare la colonia penale di Kafka con l’Isola del Diavolo dove Alfred Dreyfus fu internato dopo la sua condanna. [16]
Uno dei pochi accenni a Dreyfus appare, piuttosto indirettamente, in una lettera del 1922 a Max Brod. Kafka fa riferimento alla lotta culturale attorno a un controverso scultore ceco, František Bilek, che poi paragona a una controversia analoga attorno al compositore ceco Leoš Janá?ek. Secondo Kafka, la difesa di Bilek da parte di Brod è: “una lotta paragonabile alla lotta per Janá?ek; se ho capito bene (avrei quasi scritto: alla lotta per Dreyfus)”. [17] Non si tratta certo di un’affermazione potente sull’affare Dreyfus, assimilato a una controversia estetica… Ma si può accettare l’ipotesi che, in misura minore rispetto ad altri processi antisemiti, quello contro il capitano ebreo francese fosse tra le fonti di ispirazione di Kafka per il romanzo.
Molto più decisa fu la sua reazione al processo Hilsner in Cecoslovacchia, per l’ovvia ragione che si svolse nel suo Paese. Nonostante la sua giovane età nel 1899 (sedici anni), Kafka comprese immediatamente il significato minaccioso di questa vicenda. In quell’anno un giovane ebreo ceco, Leopold Hilsner, residente nella città di Polna, fu accusato di “omicidio rituale” ai danni di una giovane cristiana, Agnes Hurza, al fine di utilizzare il suo sangue per i riti pasquali ebraici. Riconosciuto colpevole, nonostante l’assenza di prove, Hilsner fu condannato alla pena capitale e scampò alla morte solo grazie alla campagna in sua difesa condotta dal politico democratico Thomas Masaryk (futuro Presidente della Repubblica Ceca); in seguito a una revisione del processo, fu “solo” condannato all’ergastolo. [18]
In una conversazione riportata da Gustav Janouch, Kafka menziona le sue discussioni su questo episodio con l’amico e compagno di scuola Hugo Bergmann, come punto di partenza della sua consapevolezza della condizione ebraica: ‘un individuo disprezzato, considerato dal mondo circostante come uno straniero, solo tollerato’ [19] – in altre parole, un paria …
Sappiamo che gli appunti di Janouch non sono sempre attendibili, ma abbiamo, nella corrispondenza di Kafka con Milena, un riferimento diretto al caso Hilsner, come esempio paradigmatico dell’irrazionalità dei pregiudizi antisemiti: “Non riesco a capire come la gente (…) sia arrivata a questa idea dell’omicidio rituale”; in una sorta di scenario fantasmagorico, “si vede ‘Hilsner’ commettere il suo crimine passo dopo passo”. In questa corrispondenza con il suo amico e amante, ci sono diversi altri riferimenti all’antisemitismo, un’ideologia in cui tutti gli ebrei “assumono la forma dei negri” e costituiscono una razza inferiore, la “feccia della terra”. [20]
Infine, è molto probabile che Kafka sia stato profondamente toccato anche dal processo contro il calzolaio ebreo russo Mendel Beiliss (Kiev, 1911-1913), accusato anch’egli di “omicidio rituale” – un processo seguito da una violenta campagna antisemita sulla stampa e da rivolte antisemite a Kiev. Il periodico sionista Selbstwehr , a cui era abbonato, era ossessionato da questa vicenda, che mostrava, in modo impressionante, la drammatica condizione degli ebrei nell’Impero zarista russo: la loro assenza di diritti, la loro esclusione sociale, la loro persecuzione da parte dello Stato. Ad esempio, un editoriale intitolato “Kiev”, del 12 aprile 1912, afferma: come ai tempi del processo Dreyfus, anche ora, a Kiev, “tutti gli ebrei del mondo si sentono dalla parte degli imputati”, insieme a Beiliss. La condanna di Mendel Beiliss sarebbe stata il segnale per “scatenare una tempesta legalizzata contro gli ebrei” in Russia. Nell’estate del 1913, il processo era diventato così noto sulle pagine di Selbstwehr che il nome dell’imputato veniva spesso cancellato e la vicenda veniva semplicemente chiamata ” Der Prozess”… [21]
Sappiamo che tra le carte di Kafka, che chiese di bruciare alla sua amica Dora Diamant poco prima della sua morte, c’era un racconto su Mendel Beiliss. [22] Questo fu forse il processo che influenzò più direttamente Der Prozess , poiché ebbe luogo solo un anno prima che Kafka iniziasse a scriverlo.
Il ruolo dei processi antisemiti come fonte del romanzo è solo un’ipotesi. Ma è plausibile, considerando anche che, dal 1911, dopo l’incontro con il teatro yiddish e l’amicizia con l’attore Itzhak Löwy, Kafka si interessò sempre di più all’ebraismo e iniziò a inviare alcuni dei suoi scritti a periodici ebraici come il già citato Selbstwehr o Der Jude , il diario di Martin Buber.
Tuttavia, non c’è nulla, nel romanzo, che tradisca un collegamento diretto con i processi antisemiti . È vero che l’arresto di Joseph K sembra essere il risultato di una “calunnia” – un termine che sembra avere una certa analogia con le accuse di “omicidio rituale”. Tuttavia, la questione della calunnia non viene affrontata nel romanzo. Infatti, non ci sono riferimenti agli ebrei e/o all’antisemitismo ne Il Processo , né direttamente né indirettamente. Il personaggio principale, Joseph K, ha poco in comune né con il capitano Dreyfus, né con Hilsner, la famiglia Scharf di Tisza e Mendel Beiliss. Ciò che è comune tra i processi antisemiti e il romanzo è un certo schema di assurda e ingiusta procedura “legale”, e lo schiacciamento dell’individuo innocente sotto le ruote della macchina statale. In altre parole: se Franz Kafka era profondamente preoccupato per i processi antisemiti, non vi reagì solo come ebreo, ma anche come spirito universale, che scopre nell’esperienza ebraica la quintessenza dell’esperienza umana nei tempi moderni. Ecco perché in Der Prozess il personaggio principale, Joseph K., non ha nazionalità né religione: la scelta di una semplice iniziale al posto di un nome – K e non Kohn o Kreuzer – è un forte significante di questa identità universale. Joseph K potrebbe essere una qualsiasi delle innumerevoli vittime dell’apparato giudiziario dello Stato. [23]
In questa reinterpretazione universalista dei processi antisemiti, la simpatia di Kafka per le idee socialiste libertarie ha probabilmente giocato un certo ruolo. Come è noto, grazie a diversi testimoni – Michal Mares, Michal Kacha, Gustav Janouch, tra gli altri – Kafka partecipò a diverse riunioni dei circoli anarchici di Praga, durante gli anni 1909-1912. [24] Ora, la questione dell'”ingiustizia di Stato” occupava un posto importante nella cultura libertaria, che celebra, ogni anno, il Primo Maggio, la memoria dei “Martiri di Chicago”, i leader anarco-sindacalisti giustiziati nel 1887 con false accuse. Nel 1909, un altro “affare” suscitò l’indignazione degli ambienti anarchici – e più in generale dei circoli progressisti – di tutto il mondo: la condanna alla pena capitale e l’esecuzione da parte della monarchia spagnola di Francisco Ferrer, eminente pedagogo libertario, fondatore della Scuola Moderna Spagnola, falsamente accusato di aver ispirato una rivolta anarco-sindacalista a Barcellona. Secondo il poeta anarchico ceco Michal Marès, Kafka partecipò nel 1909 a una manifestazione di protesta a Praga contro l’esecuzione di Ferrer.
A differenza delle vittime del processo antisemita, che furono assolte (Dreyfus, gli ebrei di Tisza, Beiliss) o almeno evitarono la pena capitale (Hilsner), Francisco Ferrer fu giustiziato “legalmente” e quindi presenta un tratto comune significativo con Joseph K. Ma a parte questo, non ci sono molte somiglianze tra le loro storie…
Come resistere alla macchina omicida della giustizia di Stato? Per gli amici sionisti di Kafka, i paria ebrei avrebbero dovuto organizzare la loro autodifesa – la Selbstwehr – contro l’antisemitismo, un primo passo verso una ritrovata dignità. Per i suoi amici anarchici cechi, l’unica difesa sarebbe stata l’azione diretta degli oppressi contro i poteri costituiti. Kafka probabilmente simpatizzava con entrambi; ma ciò che mostra nel suo romanzo è meno ottimista e più “realista”: la sconfitta e la rassegnazione della vittima.
La prima reazione di Joseph K alla minaccia è la resistenza, la ribellione (individuale): denuncia, protesta ed esprime, con sarcasmo e ironia, il suo disprezzo per l’Istituzione che dovrebbe giudicarlo. Tende anche a sottovalutare il pericolo. I personaggi a cui chiede aiuto gli consigliano di sottomettersi: “Non c’è modo di lottare contro la Corte, se si è costretti a confessare. Dovresti quindi confessare ( das Geständnis machen ) alla prossima occasione”, gli spiega Leni, la domestica dell’Avvocato; l’Avvocato stesso dice a K che dovrebbe “rassegnarsi ( abzufinden ) alla situazione così com’è” e non muoversi: “Soprattutto non attirare l’attenzione! Stai zitto anche se questo ti sembra un’assurdità!” [25] Joseph K. rifiuta questo consiglio “amichevole”, prova solo disprezzo per questi personaggi sottomessi e servili, descritti come “canini”.
Il cane, in molti romanzi di Kafka, è la figura allegorica della servitù volontaria, del comportamento di coloro che si prostrano ai piedi dei superiori gerarchici e obbediscono ciecamente alla voce del padrone. Ad esempio, ne Il Processo, l’avvocato Huld “si umilia come un cane ( hündische weise) davanti al tribunale”. A un livello gerarchico inferiore, il mercante Block si inginocchia ai piedi di Huld e si comporta in modo spregevole e servile: “Non era più un cliente, era il cane dell’avvocato. Se Huld gli avesse chiesto di infilarsi sotto il letto come in una cuccia e di abbaiare, lo avrebbe fatto con gioia”. [26] Joseph K, al contrario, mantiene la sua dignità e si rifiuta di sottomettersi a coloro che “stanno in alto”.
Tuttavia, nell’ultimo capitolo del romanzo, il suo comportamento cambia radicalmente. Dopo un breve tentativo di resistenza agli scagnozzi – “Non andrò oltre” – decide che ogni opposizione è “inutile” e si comporta nei confronti dei suoi carnefici in modo cortese ( Entgegenkommen ), in “perfetta accettazione” ( vollem Einverständnis ) dei loro obiettivi. Non solo è rassegnato al suo destino, ma sembra disposto a cooperare attivamente alla propria punizione. È solo per mancanza di forze che non riesce a compiere ciò che considera suo dovere: prendere l’arma nelle sue mani e giustiziarsi. Tuttavia, nel momento in cui i carnefici gli conficcano il coltello nel cuore, è ancora in grado di articolare, prima di morire: “come un cane!” ( Wie ein Hund!) . L’ultima frase del romanzo è un commento: “È come se la vergogna gli sopravvivesse”. [27]
Quale vergogna? Ovviamente la vergogna di morire “come un cane”, cioè in modo sottomesso, in uno stato di servitù volontaria – nel senso dato a questa parola da Étienne de La Boétie.
La conclusione del romanzo è al tempo stesso pessimista e risolutamente anticonformista. Trasmette la coscienza ebraica ribelle di Kafka, unendo compassione per la vittima e critica della sua servitù volontaria. Si può leggere quest’ultima frase come un appello alla resistenza contro l’antisemitismo e ogni altra forma di ingiustizia legale… [28]
[1] Franz Kafka, The Eight Octavo Notebooks,’ in Wedding Preparations, 114
[2] Franz Kafka, ‘Lettera a Grete Bloch, 11 giugno 1914,’ in Letters to Felice, 423
[3] F.Kafka,Journal, (8 gennaio 1914), Parigi, Grasset, 1954, p. 321.
[4] Franz Kafka, Briefe 1902-1924,Francoforte sul Meno, Fischer Verlag, 1975, p. 337
[5] Erich Heller, Franz Kafka, Rizzoli, Torino, 1982, pp. 79-80
[6] Casten Schlingmann, Franz Kafka, Stoccarda, Reclam, 1995, p. 44
[7] F.Kafka, Der Prozess, Francoforte, Fischer, 1985, p. 7.
[8] Ibid.. Proclamando, in tutto il romanzo, la sua innocenza, Joseph K non mente, ma esprime un’intima convinzione. È per questo che, nel momento in cui i poliziotti si presentano per arrestarlo, pensa a uno scherzo organizzato dai suoi colleghi d’ufficio. È evidentemente la reazione di qualcuno che è in pace con la propria coscienza…
[9] H. Arendt, ‘F.Kafka’, in Sechs Essays p.128
[10] B. Brecht, ‘Sur la litterature tchécoslovaque moderne’, 1937, in Le siècle de Kafka, Paris, Centre Georges Pompidou, 1984, p.162. In un saggio pubblicato nel 1974, JP Stern propone un interessante – ma un po’ forzato – paragone tra il Processo e le procedure legali delle Corti del Terzo Reich. (JP Stern, ‘The Law of the Trial’, in F. Kuna, On Kafka : Semi-centenary Perspectives, New York, Harper & Row, 1976).
[11] Citato in W. Benjamin, Essais sur Brecht, Parigi, Maspero, 1969, p. 132, 136. Ceka e GPU erano nomi diversi della polizia politica sovietica. Secondo Brecht, nella stessa conversazione, «la prospettiva di Kafka è quella dell’essere umano caduto sotto gli ingranaggi» del potere.
[12] F.Kafka, Der Prozess, p. 9.
[13] Sono pienamente d’accordo con la tesi di Rosemarie Ferenczi, nel suo eccezionale libro, Kafka. Subjectivité, Histoire et Structures, Parigi, Klincksiek, 1975. Cfr. p. 62: ‘Kafka non ha preteso di essere il profeta delle catastrofi future, si è limitato a decifrare il male del suo tempo. Se le sue descrizioni appaiono effettivamente profetiche, è perché le epoche future sono la logica conseguenza di quelle di Kafka’.
[14] F.Kafka, Lettere a Felice, a cura di Erich Heller e Jürgen Born, trad. di James Stern e Elisabeth Duckworth, New York, Schocken Books, 1973 ; p. 530. Vedi il capitolo Kafka pianse in Sander Gilman, Franz Kafka. Il paziente ebreo, Londra, Routledge, 1995.
[15] Frederick Karl, Franz Kafka, l’uomo rappresentativo, Bologna, 1993, p. 501.
[16] Sander Gilman, Franz Kafka, Il paziente ebreo pp. 69-70, 81.
[17] F.Kafka, Briefe 1902-1924, Francoforte sul Meno, Fischer Taschenbuch Verlag, 1975, p. 402.
[18] Per un resoconto dettagliato della vicenda, vedi Maximilian Paul Schiff, Der Prozess Hilsner,Aktenauszug, Wien, 1908 e Der Fall Hilsner, ein europäisches Justitzverbrechen,Berlin, AW Hayn’s Erben, 1911. Vedi anche Rosemarie Ferenczi, Op.cit. pp. 46-58.
[19] G.Janouch, Kafka und seine Welt, Vienne, Verlag Hans Deutsch, 1965, p.55.
[20] Kafka, Lettres à Milena, Parigi, Gallimard, 1988, trad. A. Vialatte, pp.66, 164, 255.
[21] Vedi Arnold J. Band, ‘Kafka and the Beiliss Affair’, Comparative Literature, vol. 32, n. 2, primavera 1980, pp. 176-177. Beiliss fu infine assolto dalla giuria.
[22] Max Brod, Franz Kafka: eine Biographie, Frankfurt am Main, S.Fischer, 1954, p.248. Brod cita una testimonianza di Dora Dymant, l’ultima compagna di Kafka: ‘Tra le carte bruciate c’era, secondo Dora, un racconto di Kafka sul processo per omicidio rituale di Beiliss a Odessa’.
[23] Secondo Rosemarie Ferenczi, l’affare Hilsner, manipolato dallo Stato, insegnò a Kafka, al di là dei limiti della realtà ebraica, fino a che punto poteva arrivare il «comportamento arbitrario di un potere senza scrupoli». (Kafka, subjectivité, histoire et structures, p. 61). Vedi anche p. 205: «Il Processo è un atto d’accusa contro la Storia del suo tempo che ha reso possibili affari come quello di Hilsner».
[24] Su questo tema rimando al mio libro, rebellious dreamer, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2016.
[25] Kafka, Der Prozess, Francoforte, Fischer, 1985, pp. 94, 104.
[26] Kafka, Der Prozess, pp. 152, 166.
[27] Kafka, Der Prozess, pp.191-194.
[28] Peter Handke ha un commento interessante a questo proposito: ‘Non c’è negli scritti dei popoli fin dalle origini un altro testo che possa aiutare tanto gli oppressi a resistere con dignità e indignazione contro un ordine del mondo che si è rivelato il loro nemico mortale, quanto questa fine del romanzo Il Processo, dove Joseph K viene condotto al massacro e accelera lui stesso la sua esecuzione (…).’ (P. Handke, ‘Discours de réception du prix Kafka’, 1979, in Le siècle de Kafka, Paris, Centre Georges Pompidou, 1984, p.248).
Fonte: Franz Kafka and Antisemitism. The historical context of Der Prozess








Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.